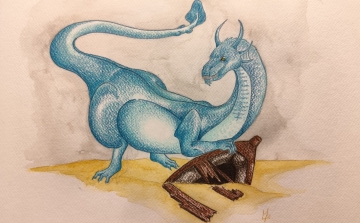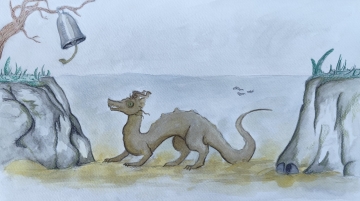I filosofi antichi lo avevano già capito. La natura non agisce per tutelare il bene degli uomini ma per perpetuare tutte le specie, inseguendo il proprio ciclo naturale: per questo, a volte, la consideravano 'matrigna'. Ed è proprio dal delicato equilibrio tra la natura e le sue leggi che deriva la perenne battaglia per la rivendicazione dei diritti naturali, intesi come quelli di tutti gli esseri viventi e non solo dei diritti umani (sui quali, peraltro, noi homo sapiens siamo erroneamente convinti di avere il pieno controllo).
Così hanno spiegato Pietro Li Causi, ricercatore in Lingua e letteratura latina all'Università di Siena, intervenuto - insieme a Piero Genovesi, responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica di ISPRA - all'ultima edizione del Festival del Classico tenutasi al Circolo dei Lettori di Torino, lo scorso dicembre.
Un interessante dialogo tra un naturalista (Genovesi) e un latinista (Li Causi) che hanno fatto viaggiare nel tempo il pubblico intervenuto, dall'antichità ai giorni nostri, incuriosendo sulle specie aliene e sorprendendo sulla percezione che l'uomo ha della natura, da tempo immemore.
Il rapporto tra l'Uomo e la Natura
Lo spiega bene Li Causi, quando cita Giacomo Leopardi che, nel Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali, 12), racconta di un uomo islandese insofferente e infelice che attribuisce il suo stato di malessere prima ai suoi vicini che lo costringono a stare in casa, poi al clima che qui respira, trattandosi di un luogo chiuso. Ecco quindi che decide di girare il Mondo alla ricerca di un posto adatto a lui e che trova, dopo un lungo peregrinare, in Africa dove incontra la Natura, che ha le sembianze di una donna enorme appoggiata a una montagna.
A lei l'islandese rivolge una serie di domande, paragonandola a un folle che tiranneggia il proprio ospite (l'essere umano) a stare in luoghi scomodi, danneggiandolo e impedendogli di andare via. Quando l'islandese chiede le ragioni del comportamento di lei evidentemente contro gli esseri umani, lei asserisce la celeberrima frase: «Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? ... Se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei...».
Per Li Causi, già nel 1824, Leopardi affermava che l'uomo non può considerarsi un abitante privilegiato del Pianeta: ed è forse per questo che conclude quest'opera con due leoni che divorano l'islandese. Un uomo sopraffatto dalla natura 'matrigna'.
Specie aliene, paurose per chi non ha fantasia!
Dal rapporto tra uomo e natura, Piero Genovesi - di cui abbiamo recensito il suo ultimo libro Specie aliene – Quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle - porta l'attenzione proprio sulle specie esotiche «paurose solo per chi non ha fantasia», afferma il naturalista. Prediamo, ad esempio, l'Eracleum: una pianta importata in Europa dal Caucaso alla fine del XIX secolo per fini ornamentali, bellissima nella sua semplicità, che si è diffusa e inselvatichita insediandosi nei prati, sulle rive dei fiumi e nei luoghi incolti, sia in pianura, sia a quote più elevate con una velocità impressionante tanto da essere considerata, in particolare nelle isole britanniche e nell'Europa orientale, una delle specie più dannose e classificata tra le 'specie aliene invasive'. Bella ma pericolosa per la tossicità cutanea e oculare della sua linfa, innescata dalla fotoesposizione, e capace di minacciare la biodiversità provocando il deperimento e la distruzione della vegetazione indigena. Una specie affascinante ma allo stesso tempo dalle potenzialità mostruose.
Gli Antichi non avevano categorie in cui classificare le specie aliene ma c'era già una certa consapevolezza sui loro effetti impattanti. Ad esempio gli antichi romani scoprirono una specie aliena di coniglio che causò parecchi danni nella Penisola Iberica.
Storicamente abbiamo le prime testimonianze del contatto con questo animale domestico negli scritti romani: nel De Re Rustica, Varrone (I sec. a.C) dà istruzioni su come sua moglie debba tenere i conigli insieme alle lepri nel suo leporarium, mentre Plinio il Vecchio (I sec. d.C) nomina per la prima volta - in Naturalis Historia - i laurices, conigli appena nati, ritenuti cibo prelibato. È questa l'unica opera dell'autore pervenutaci integralmente: un capolavoro enciclopedico dove, nel libro VIII è lo stesso Plinio, scrittore e filosofo naturalista, a scrivere di «quelle bestie che in Spagna sono chiamate cunicoli [conigli] capaci di riprodursi con un ritmo inesauribile e che provocano carestie nelle isole baleari» dando testimonianza di un Mondo già sulla via della globalizzazione dove specie e sementi viaggiavano per mare e per terra.
Ed è sempre in Naturalis Historia che Plinio nota che «a Cirene (un'importante città dell'Antica Grecia, ndr), le rane erano mute, e questa specie rimane ancora, benchè siano stati importati dal continente esemplari dotati di voce. Sono mute ancora oggi nell'Isola di Serifo; le stesse però, trasportate altrove, cantano, il che avviene si dice, anche sul lago Sicandro in Tessaglia». Già con Plinio il Vecchio emerge un'idea di rapporto dinamico tra specie e ambienti, gli uni influenti sugli altri, in una relazione e in una reciprocità che anticipa il pensiero di Darwin.
Specie esotiche, peregrine e cives
Gli Antichi facevano ricerche naturalistiche, ed erano già consapevoli che le specie potevano mutare. In molti testi antichi c'è l'eco di importanti ritrovamenti fossili, spesso rappresentati come mostri: gli stessi contro cui Ercole combatte nelle sue imprese eroiche.
Nell'Antichità troviamo anche il concetto di ibridazione, intesa come motore di novità biologica. È Aristotele a raccontare di specie che si incrociano e si abituano a stare insieme lungo i fiumi, mentre risale al 1792 il tentativo compiuto al British Museum di smontare i 'pezzi' degli animali che si pensava fossero mescolati nei primi esemplari di ornitorinco.
Le specie aliene nell'Antichità fanno paura: erano quelle che si trovavano al di là delle ecumene, al di là delle tratte battute che portavano verso l'India e l'Africa nera. Ed è nel tentativo di ricondurre specie ignote a specie note, che prendono vita coloriti racconti, ardite metafore e nomi nuovi di specie. Plinio il Vecchio racconta che «gli Etiopi chiamano nabu una bestia che nel collo assomiglia a un cavallo, nei piedi e nelle zampe ai bovini e nella testa ai cammelli». E troviamo sempre in Etiopia «la manticora che sa imitare la favella dell'uomo» con un triplice ordine di denti uniti a forma di pettine, che ha il volto e le orecchie umani, gli occhi glauchi, un colore sanguigno, il corpo leonino, la coda che punge come quella di uno scorpione.
Dalle specie esotiche, vanno distinte quelle peregrine (cioè che si sono acclimatate a nuove condizioni ambientali) e le cives (cioè autoctone, degne di cittadinanza): queste sono le distinzioni care al filosofo naturalista.
Oggi, nel XXI secolo, a differenza dell'Antichità, conosciamo molte delle specie che abitano il nostro Pianeta ma ci sono ancora molti angoli di Mondo inesplorati.
Delle 37mila specie aliene note, solo 3500 sono dannose. Questa enorme varietà di biodiversità naturale ha bisogno di un importante sforzo di conservazione per preservare quel 'prodigio' naturale alla continua ricerca di un dinamico ma delicato equilibrio, che gli Antichi avevano già individuato e compreso benissimo.