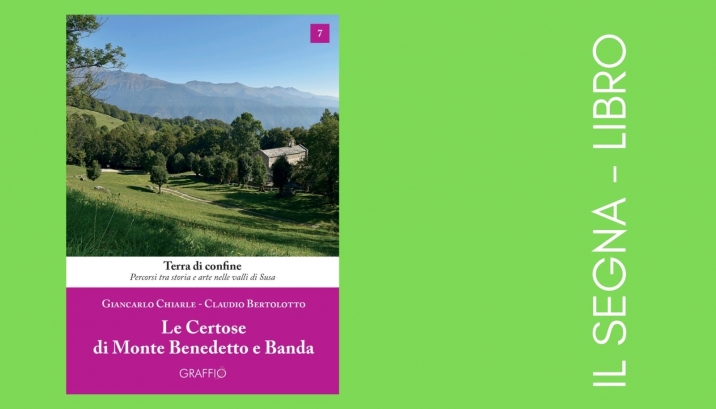Se vi capita di passeggiare in alta Val Susa e di sentir parlare di come si otteneva l'olio dalle marmotte, ricordatevi della celebre frase che campeggia sui titoli di coda di molti film: nessun animale è stato maltrattato durante le riprese.
La "marmotta" in questione è una pianta endemica delle Alpi occidentali - il pruno del Delfinato (Prunus brigantina) - diffusa nelle aree più elevate delle valli occitane piemontesi e nelle zone francesi di Briançon e del Queyras.
Adatto al clima secco e ai suoli aridi e ben esposti al sole, vegeta abbondantemente sopra i 1200 metri di quota, il che ne fa l'albero da frutto con l'areale più alto d'Europa.
Durante la primavera inoltrata sbocciano i fiori che, riuniti in mazzetti, colorano di bianco i rami ancora nudi, fino a lasciare il posto a piccole drupe dorate, simili a grosse ciliegie o piccole albicocche.
Il paragone con i prelibati frutti consumati da tutti non è infondato, perché il nostro pruno è parente proprio dell'albicocco, del pesco, del prugnolo e del ciliegio, con la particolarità di essere l'unico Prunus originario dell'Europa occidentale.
Una pianta molto occitana
Andando a cercare tra i ricordi delle genti delle vallate occitane appaiono molti nomi diversi con i quali la nostra pianta è stata chiamata: affatouyé, fatouléra, l'piora, l'brignìë e, più singolare di tutti per le nostre orecchie, l'marmutìë, da cui il termine marmottë, usato per indicarne il frutto.
Ecco spiegato il perché dell'olio di marmotta, ottenuto da un lungo e complesso processo di lavorazione, tramandato per secoli di generazione in generazione.
I nòccioli, una volta liberati dalla polpa aspra e allappante che li circonda, venivano rotti uno a uno per liberare i semi, a loro volta portati al frantoio per essere frantumati e ridotti in poltiglia. La pasta grassa e omogenea che ne derivava, una volta riscaldata e strizzata in un panno di canapa, liberava un olio dolce e profumato, da consumarsi con insalate e verdure cotte.
Liberare manualmente ogni seme dal duro involucro, per quanto possa oggi sembrare strano e anti-economico, trovava un tempo valide ragioni per i produttori. Nonostante servissero ben due chili di semi per ottenere un solo litro di olio, il clima rigido e l'altitudine elevata non permettevano la presenza di altre essenze più produttive, come il noce o l'olivo. Inoltre, i lunghi mesi invernali davano la possibilità e il tempo di occuparsi di questa incombenza, lunga e ripetitiva, senza togliere spazio ad altri lavori. C'è da dire poi che il valore dell'olio di marmotta era tutt'altro che irrilevante: un solo litro veniva scambiato, quando possibile, addirittura con due litri di olio d'oliva o di noce.
A Salbetrand, ancora i segni della tradizione
Nonostante oggi l'olio di marmotta non venga più prodotto - le ultime produzioni italiane sono attestate in Val Susa nei primi decenni del secolo scorso - i più attenti potranno ancora osservare i segni di questa pratica in alcuni mulini di montagna, come ad esempio in quello di Salbertrand, all'interno di un parco naturale regionale e oggi gestito dall'Ecomuseo Colombano Romean.
Su una macina di pietra ben conservata è chiaramente visibile il piccolo e apparentemente insignificante incavo nel quale, con inesorabile pazienza, venivano posti, uno alla volta, i nòccioli di marmottë per essere pestati fino alla liberazione del seme.
Di questa pratica artigianale e della sua storia - un vero e proprio spaccato di vita delle valli occitane – oggi rimangono solo questi pochi indizi ma la pianta che un tempo contribuiva al sostentamento di queste popolazioni è ancora qui: uno dei tanti simboli che lega l'uomo e la sua montagna.

![pruno del Delfinato Krzysztof Ziarnek, Kenraiz [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] pruno del Delfinato Krzysztof Ziarnek, Kenraiz [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]](/cms/media/k2/items/cache/765270ac82d01142afd62eba00f273bb_XL.jpg)