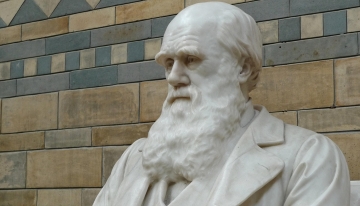Ogni volta che si verifica un fenomeno estremo, legato a una piena fluviale o ad una esondazione, con ingenti danni materiali e costi drammatici anche in termini di vite umane, si accendono polemiche e discussioni legate alle cause e alle possibilità di prevenzione. I numerosi eventi alluvionali che si sono verificati negli ultimi anni hanno messo prepotentemente in luce il difficile rapporto che si è instaurato tra i cosiddetti anthropogenic landscapes – gli ambienti antropizzati – e le dinamiche idromorfologiche proprie dei sistemi fluviali.
Come gestire i corsi d'acqua e tutelare gli ecosistemi?
L'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e lago Maggiore, che gestisce i parchi fluviali di importanti corsi d'acqua (quali la Sesia ed il Ticino) ha organizzato lo scorso 29 novembre - a Villa Picchetta a Cameri - una serata di divulgazione aperta a tutti i cittadini, con la presenza di autorevoli relatori in materia, per chiarire tali argomenti. La serata è stata l'occasione per spiegare come si può intervenire nella gestione di un corso d'acqua e come difendere attivamente i preziosi ecosistemi soggetti nel tempo ad un impatto umano che è spesso più dannoso che benefico. Infatti è ormai ampiamente riconosciuto che alcuni interventi antropici (come ad esempio le escavazioni di materiale litoide) determinano la riduzione di sedimento e sono quindi alla base della perdita di habitat e biodiversità e della riduzione dei preziosi servizi ecosistemici che i sistemi fluviali offrono all'uomo.
Il convegno (che ha registrato un "tutto esaurito" di presenze) era costituito da un pubblico eterogeneo: dal personale attivamente impegnato sul campo (Protezione Civile, AIB), alle guide naturalistiche ed ambientali, studenti ed insegnanti, fruitori a vario titolo dei corsi d'acqua (pescatori, proprietari di immobili costruiti in prossimità di fiumi), rappresentanti di Enti ed associazioni di svariato tipo, ma anche semplici cittadini interessati agli argomenti trattati. Un segnale importante di sensibilità e attenzione alle tematiche ambientali - in genere - e, nello specifico, a quelle riguardanti la gestione fluviale.
Il convegno in sintesi
Introdotti dalla Direttrice dell'Ente parco, arch. Monica Perroni, i lavori hanno succedersi gli interventi di esperti in materia.
"La gestione dei fiumi non può consistere solo nella realizzazione di opere: deve essere inclusa in un più ampio quadro strategico di sviluppo del territorio e uso del suolo definito sulla base di specifici obiettivi e che mira a ristabilire processi geomorfologici dinamici in grado di perseguire un efficace e sostenibile recupero dell'ambiente fluviale e una mitigazione del rischio geo-idrologico, nell'ottica dell'implementazione delle direttive europee in materia di acque (Direttiva 2000/60/EC) e di alluvioni (Direttiva 2007/60/EC)" ha spiegato Andrea Mandarino, ricercatore dell'Università di Genova, che illustrato le caratteristiche specifiche dei parchi fluviali gestiti dall'Ente ospitante, ossia i fiumi Sesia e Ticino, e poi si è soffermato sugli aspetti più strettamente tecnici riguardanti la geomorfologia dei sistemi fluviali e la loro gestione,
Le questioni più strettamente tecniche e legali, quali il Regolamento vigente dell'Unione Europea per il ripristino della natura e la connettività fluviale, le direttive e gli obblighi derivanti ma anche l'offerta di opportunità legate a ingenti finanziamenti per mettere in atto determinati interventi sono state illustrate dall'ingegner Andrea Goltara, direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale o CIRF, associazione culturale tecnico-scientifica senza fini di lucro che promuove concretamente la riqualificazione fluviale tramite progetti sul territorio
Le conclusioni dei lavori
In definitiva non esiste un criterio unico e sicuro per risolvere le criticità geo-idrologiche di un territorio, perché ogni bacino idrografico rappresenta un caso a se' stante. E' comunque prioritario ridare spazio ai corsi d'acqua, fermare il consumo di suolo a livello di bacino, non occupare ulteriormente con insediamenti le aree soggette a pericolosità geo-idrologica, ridurre gli elementi esposti, creare aree di laminazione diffusa, importanti per la mitigazione del rischio e, nell'ottica della riqualificazione fluviale, per la riconnessione delle pianure agli alvei, usando il suolo stesso come "difesa".
I fiumi connettono i monti al mare, le persone e le culture, caratterizzano il paesaggio e costituiscono una riserva di biodiversità: è necessario un cambiamento culturale, sia a livello di comportamento ed azioni di comuni cittadini che di normative e scelte politiche e gestionali adottati dalle istituzioni pubbliche, allo scopo di migliorare le condizioni degli ecosistemi fluviali perché questi costituiscano una risorsa per le popolazioni e non una minaccia per la incolumità delle personale e dei loro beni materiali.