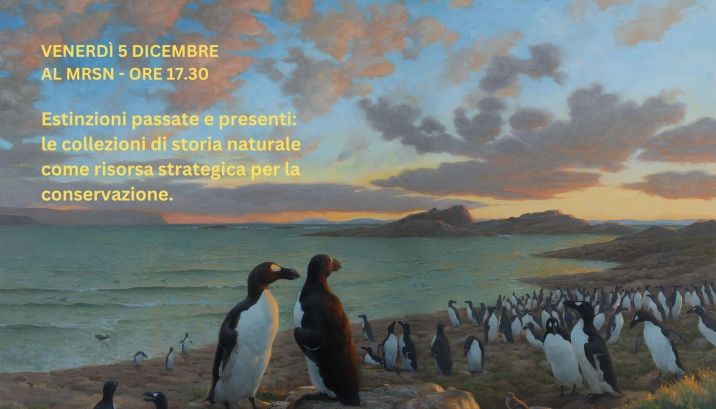Come sono cambiate le idee sulla speciazione dalla pubblicazione de L'origine delle specie di Darwin a oggi? Nonostante il titolo, molti evoluzionisti del Novecento lo hanno accusato di non aver compreso bene l'argomento che dà il titolo al libro. Ciò è avvenuto perchè l'idea di specie che Darwin aveva in mente era radicalmente diversa da quella che abbiamo noi, e dunque diversi erano nella sua mente i meccanismi che portano all'origine di una nuova specie.
Le cose sono cambiate, e accanto ai meccanismi di speciazione generalmente accettati dalla "Sintesi Moderna" ne sono stati proposti molti altri. In questa logica, soprattutto nell'ambito della "Speciazione ecologica" molte delle idee proposte da Darwin sono state quindi recuperate.
E' ciò che ci spiegherà mercoledì mercoledì 5 febbraio, al Museo Regionale di Scienze Naturali, Marco Ferraguti che ha insegnato Evoluzione Biologica all'Università degli Studi di Milano, appassionato ricercatore nel campo della riproduzione e filogenesi in diversi gruppi di invertebrati, tra i fondatori e, per un periodo, presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica.
Lo abbiamo intervistato sull'argomento, in anteprima. Ecco cosa ci ha raccontato.
Professore Ferraguti, cosa ascolteremo al Museo Regionale di Scienze Naturali, il 5 febbraio?
Racconterò – almeno in parte – e cercherò di dimostrare che le idee sulla speciazione conseguono alle idee sulla natura delle specie. Se uno crede che le specie siano definite dalla loro nicchia ecologica, allora la domanda sulla speciazione diventerà: "Come può una specie occupare un'altra nicchia ecologica?". Al contrario, se uno vede una specie come una comunità riproduttiva, allora la domanda diverrà: "Come si forma isolamento riproduttivo fra una specie derivata e una originale?"
Le risposte alle due domande non coincideranno: è chiaro ad ogni naturalista che una specie ha un'identità ecologica, una morfologica e una riproduttiva. Ma purtroppo, il raggiungimento di queste identità viaggia spesso a velocità diverse.
Perché oggi è importante parlare di Darwin?
Perché Darwin è una personalità immensa, ma mai banale. Basta leggere i suoi taccuini – in parte disponibili anche in italiano - per scoprire un uomo complesso e pieno di spunti che vanno in direzioni diverse. Nel suo studio di casa leggeva di tutto, dalla teologia alla filosofia ai saggi di politica, ai romanzi (che si faceva leggere ogni sera dalla moglie, con particolare predilezione per quelli "che finivano bene") e manteneva corrispondenze con decine di persone: dai giardinieri ai numismatici, dagli storici ai botanici e ai viaggiatori. Si potrebbe dire che le lettere – e le relative risposte – abbiano tenuto nella sua mente il posto che oggi è occupato dai risultati dei motori di ricerca su Internet. Le circa 15mila lettere finora pubblicate in trenta corposi volumi testimoniano di una attività e una vastità di interessi che – ahimè – è assente dal lavoro di molti scienziati di oggi. Un altro aspetto che trovo interessante è che fra i suoi circa 2000 corrispondenti si trovano relativamente pochi accademici. D'altra parte nemmeno lui era un accademico, ma semplicemente un attento osservatore e studioso della natura
Qual era l'idea di specie che aveva Darwin?
I primi evoluzionisti – Lamarck, Darwin, Haeckel - almeno a parole negavano l'esistenza delle specie. Ciò accadeva per motivi che non esiterei a definire "ideologici": se tu vuoi che i tuoi lettori credano nel cambiamento della vita nel tempo (l'evoluzione), e ti trovi di fronte alle specie di Linneo, che con la loro rigorosa codifica sembravano dire "o sei così o sei cosà", l'unica soluzione possibile è abbattere quella barriera. Così Darwin scrive nell'Origine: "... Dovremo trattare le specie come i naturalisti trattano i generi, ossia come mere combinazioni artificiali fatte per convenienza. Non sarà una gran bella prospettiva, ma almeno ci libereremo dalla vana ricerca dell'essenza sconosciuta e introvabile del termine specie". Ma naturalmente Darwin sapeva bene che le specie esistevano ed erano qualcosa di particolare, e si scontrava con la loro natura quotidianamente: "Dopo aver descritto un insieme di forme come specie distinte, strappo il mio manoscritto e le considero un'unica specie, poi strappo anche questo e torno alle specie distinte, e poi nuovamente a un'unica specie; quando mi succedeva così, digrignavo i denti, maledicevo le specie, e mi domandavo quale peccato avessi commesso per essere punito dalla sorte" (lettera ad Asa Gray del 25 sett 1853).
Perché l'idea di specie di Darwin è diversa da quella attuale?
Oggi, accettata da tutti l'idea di evoluzione, si cerca un approccio alle specie che tenga conto della loro apparente stabilità e identificabilità da un lato, e del cambiamento nel tempo dall'altro. Una definizione che metta d'accordo tutti non è ancora stata trovata, anche per motivi intrinseci: se la specie è una comunità riproduttiva, che fare delle "specie" che non si riproducono sessualmente? Che fare di quelle "specie" che si incrociano liberamente e producono ibridi fertili? Il dibattito ferve.
Cosa trova di affascinante della teoria di Darwin e di Wallace ancora oggi?
La cosa che mi affascina di più è la contemporaneità della scoperta: due persone, Darwin e Wallace, che più diverse di così è difficile immaginare, lavorando da parti opposte del Mondo, hanno "visto" gli stessi fenomeni e sono arrivati alle stesse conclusioni. Non c'è nulla di magico in ciò: entrambi erano immersi in un'atmosfera fertile per le idee che avrebbero prodotto (l'ambiente scientifico della Gran Bretagna), e sebbene uno (Darwin) abbia viaggiato per il mondo una sola volta, da giovane, e l'altro (Wallace) continuasse a battere i tropici, il loro ragionamento fu simile, pur con differenze fra l'uno e l'altro.
Cos'è la 'speciazione ecologica' e perché è importante?
"La speciazione ecologica è definita come l'evoluzione di isolamento riproduttivo fra popolazioni causato da selezione naturale divergente dovuta a differenze ecologiche. [...] Gli agenti della selezione divergente sono estrinseci e possono includere fattori abiotici e biotici, quali risorse alimentari, clima, habitat, interazioni interspecifiche, quali malattie, competizione e interferenze comportamentali" (Schluter, Science, 323, 737, 2009). L'importanza di tale modello è dovuta al fatto che non prevede isolamento geografico, e dunque può avvenire in presenza di scambio genico in un popolazione.
Per i sostenitori più tradizionali della Sintesi Moderna, per i quali la separazione geografica era il prerequisito indispensabile alla speciazione, questo è veramente difficile da accettare.
Qual è il fenomeno evoluzionistico più sorprendente che ha studiato?
Per riallacciarmi alla risposta successiva: quando mediante lo studio degli spermatozoi e della spermiogenesi di un gruppo animale abbiamo potuto suggerire la relazione filogenetica di quelle specie con specie apparentemente lontane. Sto pensando, ad esempio, al lavoro fatto con il collega Giulio Melone sugli spermatozoi dei seisonidei, un piccolo gruppo di rotiferi marini parassiti, che abbiamo trovato essere quasi identici a quelli degli acantocefali, un phylum oggi, in seguito a molte altre indagini, collassato all'interno dei rotiferi. Per noi una grande soddisfazione!
Perché studiare gli spermatozoi negli invertebrati?
Gli spermatozoi degli invertebrati hanno spesso delle forme molto complesse e affascinanti. Ho imparato a usare il microscopio elettronico dal mio maestro, Giulio Lanzavecchia, che all'epoca si interessava di genesi delle forme delle cellule. E quando ho cominciato a lavorare per la tesi di laurea stava studiando la morfogenesi degli spermatozoi in Tubifex tubifex, un comune anellide oligochete delle acque dolci. Altre persone del nostro laboratorio studiavano il medesimo processo negli spermatozoi dei lombrichi e degli irudinei. Questo mi ha introdotto allo studio comparato degli spermatozoi degli invertebrati con l'idea di usare gli spermatozoi – come detto spesso estremamente complessi - come caratteri per indagare le filogenesi.
Finita la spiegazione "scientifica" vorrei però cercare di comunicarvi l'indescrivibile piacere che ho provato quando mi sedevo al microscopio a guardare gli spermatozoi di una specie mai vista prima (e a volte, nuova per la scienza): simile, credo, a ciò che prova un alpinista nel salire la prima volta una cima inviolata. Ricorderò, penso, per tutta la vita, l'emozione che ho provato quando guardammo gli spermatozoi di due gastrotrichi Xenotrichulidae che la letteratura affermava avere due flagelli – un carattere che avrebbe potuto avvicinare i gastrotrichi ai "platelminti" - per scoprire che invece si trattava di due acrosomi! Abbiamo "capovolto" l'interpretazione.
Talk: L'origine delle specie, da Darwin a oggi.
Quando: Mercoledì 5 febbraio
Dove: Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali (via Accademia Albertina, 15)
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria: ISCRIVITI SUBITO QUI!