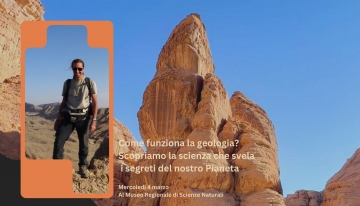Le alluvioni sono fenomeni naturali comuni, associati alla dinamica fluviale, che si trasformano in calamità quando coinvolgono persone, beni e servizi. L'uso del suolo nei bacini idrografici e gli interventi dell'uomo lungo le aste fluviali influiscono sull'intensità e sulle conseguenze delle piene, perlopiù incrementando il rischio geo-idrologico a fronte di una generalizzata occupazione delle aree fluviali e canalizzazione degli alvei.
È ben noto che le piene possono causare la perdita di vite umane e provocare ingenti danni agli edifici e alle infrastrutture, con conseguenze catastrofiche in termini sociali, economici e ambientali: il loro studio è quindi essenziale in ottica preventiva. Nello specifico, la conoscenza delle dinamiche di piena di un corso d'acqua e dei relativi effetti morfologici in alveo e nel territorio circostante è un elemento cruciale per la valutazione e la zonizzazione della pericolosità geo-idrologica, ovvero per l'assunzione di misure gestionali.
La grande piena dell'Orba
Il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università degli Studi di Genova e l'Istituto per la Protezione Idrogeologica del CNR hanno recentemente pubblicato uno studio di carattere idromorfologico sull'evento alluvionale che ha interessato l'asta fluviale del Torrente Orba il 21 e 22 ottobre 2019, causando l'allagamento di vaste aree e l'attivazione di processi di modellamento fluviale in alveo e nella pianura alluvionale inondata. Gli effetti al suolo e le dinamiche di piena sono stati definiti e valutati quantitativamente al fine di sviluppare un quadro conoscitivo fondamentale ai fini gestionali.
La ricerca, condotta lungo il tratto di pianura del torrente Orba che si estende per 23 km tra Pratalborato (Capriata d'Orba) e la confluenza con il Fiume Bormida, e include la Riserva Naturale del Torrente Orba, si è basata su rilievi geomorfologici sul campo, rilievi topografici di dettaglio e fotointerpretazione di immagini aeree.
Il Torrente Orba, tra Liguria e Piemonte
Il Torrente Orba nasce vicino a Genova, presso il versante Nord del Monte Reixa (1.183 m s.l.m.), dove il crinale che separa il bacino idrografico del Po da quello dei piccoli bacini liguri costieri si trova ad appena 5 km di distanza dalla costa, ovvero nel cuore degli Appennini che respirano aria di mare. Dopo un percorso di circa 73 km che si sviluppa verso Nord, l'Orba sfocia nel fiume Bormida presso Alessandria, drenando un bacino idrografico di 797 km2 prevalentemente boscato nella zona montana e agricolo nelle aree collinari e di pianura. I suoi affluenti principali sono i Torrenti Stura di Ovada, Piota, Albedosa e Lemme.
Il clima del bacino dell'Orba è nel complesso caratterizzato da estati calde e asciutte, e inverni freddi e umidi, con le piogge concentrate prevalentemente nella stagione autunnale; la precipitazione media annua varia approssimativamente tra 600 mm, presso Alessandria, e 1700 mm nella parte alta del bacino.
In quest'ultima, la vicinanza al mare e l'effetto topografico del rilievo si traducono in elevati valori di precipitazione annua e in frequenti eventi intensi di pioggia. Tali dinamiche sono associate a una circolazione atmosferica che comunemente si instaura sul Mar Ligure, la quale convoglia masse d'aria umida dal mare ai rilievi intorno a Genova. Questo contesto rende il bacino dell'Orba particolarmente incline a essere interessato da eventi alluvionali significativi.
I numeri della piena eccezionale
Dal 18 al 21 ottobre 2019 piogge intense e prolungate si sono abbattute sull'intero bacino, ma la fase più critica si è registrata tra il pomeriggio e la sera di lunedì 21, quando una cella temporalesca, formatasi sul Mar Ligure, ha stazionato per circa 12 ore sul Piemonte meridionale, causando precipitazioni copiose e intense: basti pensare ai valori di pioggia di 450,6 mm e 428,4 mm misurati in 12 ore, tra le 14 del 21 ottobre e le 2 del 22 ottobre, rispettivamente a Campo Ligure (Provincia di Genova) e a Gavi Ligure (Provincia di Alessandria).
In conseguenza, si è formata una piena eccezionale del Torrente Orba, il cui tempo di ritorno è stato stimato in 500 anni (cioè, in termini probabilistici, c'è una possibilità su 500 che una piena di tale entità si verifichi nell'arco dell'anno, ogni anno). A Casalcermelli è stato raggiunto il livello idrometrico di 7,5 metri con una portata al colmo, probabilmente sottostimata, di circa 2700-2800 m3 al secondo.
L'esondazione del Torrente Orba ha causato l'allagamento di un'area totale di circa 17,65 km2, in prevalenza agricola (66,2%) e naturale (17,8%). Contemporaneamente, vaste porzioni di pianura alluvionale sono state inondate da affluenti, canali di irrigazione e fossi.
Le conseguenze dell'evento sono state molto gravi sotto ogni punto di vista: versanti compromessi, infrastrutture e fabbricati danneggiati e, fatto ancora più triste, si è registrata anche una vittima.
Dal punto di vista geologico la piena ha innescato processi erosivi e deposizionali che hanno interessato sia l'alveo che la pianura alluvionale.
I processi di erosione
In generale, sono state documentate una evidente movimentazione dei sedimenti in alveo, una riattivazione dei processi di scalzamento delle difese spondali e alcuni allargamenti localizzati dell'alveo. A differenza di quanto documentato da precedenti studi su altri corsi d'acqua italiani, l'alveo attivo non ha subito significative variazioni planimetriche nonostante la rilevanza dell'evento. Questo aspetto è con ogni probabilità associato alla progressiva incisione e alla canalizzazione dell'alveo dell'Orba avvenute nel corso del ventesimo secolo, le quali hanno fortemente condizionato le dinamiche morfologiche.
Le aree inondate sono state interessate da processi di erosione superficiale e sedimentazione che hanno plasmato forme e depositi già esistenti o di neoformazione danneggiando coltivazioni, strutture e infrastrutture.
Le evidenze morfologiche documentate rivelano che la piena è defluita piuttosto rapidamente sulla pianura raggiungendo altezze idrometriche massime di circa 2-3 m, sopra il piano campagna, nello spazio compreso tra gli argini (attenzione a non confondere gli argini – manufatti per la difesa dalle esondazioni - con le sponde – scarpate più o meno marcate che delimitano il letto del fiume).
Inoltre, è risultata significativa l'interferenza delle strutture realizzate dall'uomo (strade, argini e cave) sulla propagazione della piena e quindi sull'innesco dei processi erosivi e deposizionali registrati.
L'interferenza dell'uomo
Tristemente degna di nota è la presenza di riempimenti costituiti da rifiuti in alcune aree prossime all'alveo. Presso la confluenza con il fiume Bormida, in particolare, la piena ha ulteriormente eroso una sponda in arretramento da alcuni anni, costituita da uno strato di rifiuti sotterrati di alcuni metri di spessore, i quali sono stati trascinati dalla corrente verso valle.
L'allagamento di aree esterne alla fascia delimitata dagli argini, causato non solo da preesistenti brecce non riparate, perdite legate a condotte non gestite o tane di animali, e collassi arginali di causa ignota, ma anche dal semplice sormonto del manufatto arginale stesso, dovrebbe far sorgere seri dubbi circa l'adeguatezza dell'attuale sistema difensivo. Questo evento, infine, costituisce un ulteriore esempio di come i canali abbandonati (cosiddetti paleoalvei) siano sedi preferenziali di deflusso sulla pianura durante le piene, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di pericolo e rischio geo-idrologico.
In base alle informazioni disponibili, la piena del 21-22 ottobre 2019 ha mostrato dinamiche analoghe e ha provocato effetti al suolo simili ma più intensi rispetto ai più rilevanti eventi alluvionali verificatisi lungo il Torrente Orba nell'ultimo decennio.
Nell'ambito della ricerca condotta è stato realizzato un elaborato cartografico in scala 1:15.000 raffigurante gli effetti al suolo della piena e le sue dinamiche. Tali elementi sono stati rappresentati tramite una legenda che contribuisce a incrementare l'ampio spettro di strumenti disponibili nell'ambito della cartografia geomorfologica.
Non esiste un criterio unico e sicuro per risolvere le criticità geoidrologiche di un territorio; allo stesso modo è ormai evidente che la gestione dei fiumi non può consistere solo nella costruzione di opere e nella realizzazione di interventi puntuali, spesso emergenziali, avulsi dalla pianificazione e privi di una visione d'insieme su quelle che sono le dinamiche idromorfologiche complessive del sistema fluviale. I risultati dello studio costituiscono un solido quadro conoscitivo essenziale per la valutazione del pericolo geo-idrologico, nonché per la definizione di misure volte alla mitigazione del rischio geo-idrologico e alla riqualificazione dell'ambiente fluviale nell'ottica dell'implementazione delle Direttive Europee in materia di Acque (Direttiva 2000/60/CE) ed Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE).
La ricerca completa (articolo scientifico ed elaborato cartografico) è liberamente consultabile a questo link
* Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova
** Istituto per la Protezione Idrogeologica - CNR
*** Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova; Istituto per la Protezione Idrogeologica – CNR